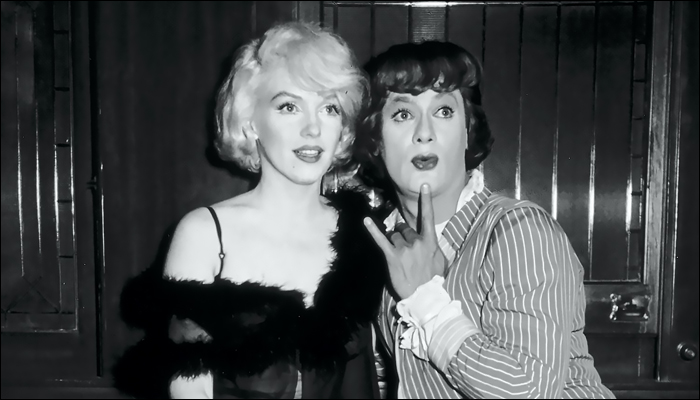Per poter illustrare il rapporto della fotografia con la verità, bisogna innanzitutto definire il significato della parola “verità”.
Nei dizionari moderni, la definizione che viene dato alla parola “verità” è: «Rispondenza al vero, alla realtà; in corrispondenza a determinati fatti; ciò che è vero in senso assoluto; sinonimo: autenticità, esattezza, ciò che è vero».
Significato del termine “verità”
“La verità” fu già messa in discussione da Socrate (469-399 a.C.) e più tardi da Aristotele (384-322 a.C.). In quei tempi, i grandi filosofi ritenevano che “la verità” fosse qualcosa di relativo. Per Socrate “la verità è la ricerca della verità” mentre per Platone (427-347 a.C.), “la verità” era un possessore dell’anima. Per Aristotele, “la verità” era la coerenza e forza logica del giudizio. Secondo Aristotele, “la verità” afferma essere quello che è e non quello che non è.
Più tardi, nel pensiero antico della cultura greca, “la verità” iniziò a delinearsi negli scritti dei naturalisti e specialmente nel poema del filosofo Parmenide di Elea: “Sulla natura” (Parmenide di Elea, circa 544-515 a.C.”). La prima parte del poema si occupa della “verità” (dal greco “alètheia”). Parmenide sostiene che l’uomo possa scegliere tra due vie: quella della verità, basata sulla ragione, che porterà alla conoscenza dell’essere vero e quella dell’opinione, basata sui sensi, che porta alla conoscenza dell’essere apparente.
Alètheia e Veritas
La parola “alètheia”, usata dai greci per indicare “la verità” ha per sua struttura semantica e lessicale un contenuto diverso rispetto all’espressione latina “veritas”. Etimologicamente il prefisso alfa con funzione privativa, precede la radice lath che significa dimenticare. Alètheia indica quindi qualcosa che non è più nascosto, che non è stato dimenticato, quindi ciò che si manifesta, che non rimane oscuro. In questo senso il termine può essere tradotto come “verità” intesa nel senso di rivelazione e di svelamento. Diverso, dunque, dal concetto greco di “alètheia” è il concetto romano di “veritas”.
Fu l’Imperatore Cicerone (106-43 a.C.) che tradusse il termine greco “alètheia” con il sostantivo latino “veritas”. I romani denominavano con questo termine l’antica dea della verità, figlia di Saturno (Crono in greco) e sorella di Giove (Zeus in greco) che si pensava avesse la sua dimora nei pozzi. Bevendo l’acqua del pozzo, i sapienti attendevano, durante la notte, di avere dalla dea Veritas i responsi dell’oracolo attraverso i sogni.
Più tardi, nelle discussioni medievali invece (alto medioevo 476-1000 e basso medioevo 1300-1500), intorno al tema della verità, un ruolo determinante è assunto dalla fede cristiana in un Dio creatore. “La verità” fu considerata eterna e immutabile, “una verità” identificata nella sua pienezza con Dio stesso. Il pensiero moderno filosofico, per esempio i pensieri di Descartes (Renato Cartesio, detto René Descartes, 1596-1650) e Immanuel Kant (1724-1804), considerava “la verità” secondaria al problema delle condizioni di validità della conoscenza.
Nella storia possiamo dunque distinguere diversi interpretazioni della parola “verità”.
Significato del termine “fotografia”
Il rapporto della fotografia con la verità è oggetto di discussione fin dalla nascita di quest’arte nel 1839. Con il dagherrotipo, inventato da Louis Daguerre (1787-1851) si ritiene comicnia la storia della fotografia. Lunedi 15 agosto 1839, l’inventore presentò a Parigi, presso l’Accademia delle Scienze e l’Accademia delle Arti Visivi, la sua nuova invenzione.
Ma sappiamo che già tredici anni prima di questa data, Joseph Nicéphore Niépce fu in grado di scattare la prima foto al mondo con una camera oscura. Nel 1829 Niépce iniziò a collaborare con Daguerre per sviluppare ulteriormente l’invenzione della fotografia. Niépce morì quattro anni dopo e Daguerre migliorerò da solo la nuova procedura della fotografia.
In seguito, William Fox Talbot (1800-1877) presentò alla Royal Society di Londra, soltanto pochi mesi dopo la presentazione del dagherrotipo a Parigi, la sua invenzione della lastra negativa. Tale invenzione subito non ottenne successo. Nel tempo, però, si rivelò più funzionale poiché consentiva di avere da un solo scatto diverse copie.
Scrivere con la luce
La parola “fotografia” ha origine da due parole greche: “luce” e “scrittura”. Letteralmente quindi, ”fotografia” significa “scrittura con la luce”. La definizione che diamo oggi alla parola “fotografia” è: “Processo fotochimico per mezzo del quale l’immagine di un qualsiasi oggetto, ottenuto con una macchina fotografica, viene fissato e reso permanente su un supporto di materiale sensibile ai raggi luminosi.” La definizione poetica della parola “fotografia” è: “La fotografia è il riconoscimento simultaneo, in una frazione di secondo, del significato di un evento. La fotografia è il ritratto di un preciso istante che viene immortalato. Il potere di una fotografia è un’emozione senza tempi”.
Oggi, le immagini fotografiche sono tra le fonti principali di ciò che sappiamo sul passato e sul presente. Mentre ciò che si scrive su una persona o su un evento è chiaramente un’interpretazione, le fotografie possono fare testimonianze. La fotografia intesa come documento fotografico può incriminare. Le fotografie non sono tanto rendiconti del mondo ma piuttosto pezzi di esso, miniature di realtà che chiunque può produrre o acquisire.
Fotoreporter degli anni 20-30
Nella storia della fotografia, i primi fotoreporter degli anni Venti e Trenta del XX secolo erano degli idealisti che credevano che la loro missione fosse quella di riportare nel mondo “la verità”. I più noti fotoreporter di quei tempi furono: Horst P. Horst (1906-1999), Henri Cartier-Bresson (1908-2004), Robert Doisneau (1912-1994), Robert Capa (1913-1954), Werner Bischof (1916-1954), Ernst Haas (1921-1986), Elliott Erwitt, (nato nel 1928), William Klein (nato nel 1928) e la fotografa americana Margaret Bourke-White (1904-1971).
L’inglese Roger Fenton (1829-1869) è considerato il primo fotoreporter di guerra nella storia della fotografia. Fenton scattò trecentosessanta foto della guerra in Crimea (1853-1856). Restò in Crimea da marzo a giugno del 1854, scattando foto di luoghi di battaglia e ritratti dei militari. Si ammalò poi di colera e dovette ritornare in patria.
La sua foto, Valley of the shadow of death, scattata il 23 aprile 1855, diventò la sua immagine più famosa. La valle è coperta da palle di cannoni e gli osservatori di quella foto consideravano quell’immagine “la verità”. Ma la scena fotografata non era quella vera. Un gran numero di quelle palle di cannoni fu spostato dai bordi della strada verso il centro della valle “aggiustando” la foto, per dare alla foto un impatto più forte. Le immagini di Fenton furono il primo esempio di manipolazione mediatica.
Margaret Bourke-White
Margaret Bourke-White fu la prima donna fotoreporter della storia e la prima fotografa straniera ad avere il permesso di scattare foto negli URSS. Fu la prima corrispondente di guerra donna nella seconda guerra mondiale (1940-1945).
Lei scrisse: «A volte vengo via da ciò che sto fotografando con il cuore che sanguina, con i volti della gente che soffre impressi nella mia mente come sui miei negativi. Ma vi ritorno perché sento di dover scattare quelle foto. La verità assoluta è essenziale ed è questo che mi muove quando guardo attraverso l’obiettivo.»
Il caso Robert Capa
Prendiamo anche per esempio una fotografia scattata nel 1936 dal famoso fotografo Robert Capa (1913-1954) durante la guerra civile spagnola che rappresenta un miliziano ferito a morte. Da decenni c’è un dibattito sull’autenticità (sinonimo della parola “verità”) di quella foto, un dibattito sapientemente alimentato dal fotografo stesso che giocava molto sulla figura “leggermente fuori fuoco”. Il punto è: c’era la guerra e ogni giorno civili e miliziani morivano. Alla luce di ciò, è davvero importante se quello specifico miliziano era morto nel preciso istante in cui Capa l’ha fotografato (“realtà”) o è sufficiente la rappresentazione di una morte che mostri in maniera simbolica (“concetto”), una realtà oggettiva e innegabile? Tale fotografia dona dunque soltanto “un senso della verità”. Nel rapporto della fotografia con la realtà, bisogna dunque anche considerare il rapporto tra “realtà” e “concetto”.
Fotografia e verità
Studiosi del rapporto della fotografia con la verità furono: Roland Barthes (1915-1980), saggista, critico letterario, linguista e semiologo francese; John Berger (1926-2017), scrittore, pittore, disegnatore, critico d’arte e autore teatrale britannico; Susan Sontag (1923-2004), scrittrice, filosofa e storica statunitense e Roberto “Janus” Gianoglio (1927-2020), critico d’arte italiano.
Roland Barthes dichiarò nel suo libro: La camera chiara del 1979: «Una fotografia attesta che ciò che vedo nella foto, è effettivamente stato, è esistito. Questo è una certezza. Ciò che vedo è il reale allo stato passato, un reale che non si può più toccare. La fotografia non dice ciò che non è, ma soltanto e sicuramente ciò che è stato.»
Sul rapporto della fotografia con la verità, Barthes scrisse: «… è perché la fotografia non possiede un linguaggio suo, perché cita, piuttosto di tradurre, che si dice che la macchina fotografica non può mentire. Non può mentire perché riproduce direttamente! L’unica operazione possibile per far si che una fotografia racconta una menzogna sta nell’elaborazione di tecniche come l’alterazione, il collage, la ri-fotografia. Ma in quel caso non si tratti più di fotografia, la fotografia in sé non possiede un linguaggio che possa essere “virata”. Le foto possono essere usate – e sono spesso usate – per ingannare e fornire informazioni distorte. O, piuttosto, la verità che una fotografia può dire, può difendere, è limitato. Ogni fotografia – ogni immagine – deve essere
vista ed interpretata con sguardo critico.»
Il passato diventa presente
Susan Sontag ritiene: «La fotografia è il ritratto di un preciso istante che viene immortalato. Le fotografie non sono che mere rappresentazioni, immagini della realtà come in un quadro o in un disegno. La fotografia non è una testimonianza della realtà, non solo perché la realtà può essere modificata, ma anche perché la fotografia prende sempre una particolare e singolare deformazione a secondo chi sia il produttore della stessa. Le fotografie sono un modo per imprigionare la realtà. Non si può possedere la realtà, si possono possedere immagini, non si può possedere il presente, ma si può possedere il passato.»
Una fotografia è considerata una dimostrazione lampante e inconfondibile che un dato evento o fatto è effettivamente accaduto. Ma non è “la verità” perché una foto può essere deformata attraverso numerosi espedienti come il ritaglio, la post-produzione, il fotomontaggio, il fotoritocco, ma si presume sempre che la cosa fotografata sia esistita.
Roberto “Janus” Gianoglio scrisse nel catalogo dell’evento: “Torino fotografia 1985”, relativa alla mostra di Helmut Newton: «L’arte di creare immagini…. l’ immagine artistica non è mai un’immagine “vera” ma un immagine che è piuttosto simile al vero. La differenza è enorme. L’immagine “vera” non esiste, poiché se fosse “vera” non sarebbe più immagine, ma qualcosa di molto irreale o che non appartiene più alla sfera della conoscenza umana. L’immagine ci deve sempre un po’ ingannare, cosi come l’arte è sempre un po’ l’arte degli inganni.»
Nessuno di questi “sapienti” sulla fotografia ha alcun dubbio sul fatto che una fotografia non rappresenta “la verità.”
Giovanni Verga
Lo scrittore “verista” italiano Giovanni Verga (1840-1922) che dedicò gran parte della sua vita alla sua grande passione per la fotografia, cercò senza dubbio “la verità” nella fotografia. Verga ha potuto seguire lo sviluppo della fotografia già da giovane. I primi ritratti fotografici in color seppia che egli doveva ammirare nei salotti milanesi, dopo il suo trasferimento da Catania, non potevano non rimandargli suggestioni e riflessioni circa la rappresentazione del “vero”, specie se confrontava quelle fotografie con i dipinti dei suoi antenati di famiglia.
Lo scopo di Verga fu di dimostrare il suo “vero” Sicilia attraverso la scrittura e le sue fotografie del popolo, della famiglia, del suo paese, degli amici, dei contadini. Per lui questo
era “la vera vita” e non la superficialità dei salotti milanesi. Attraverso le sue fotografie, Verga voleva trasmettere “la verità della sua Sicilia. Verga non scrisse cose specifiche sul rapporto “fotografia e verità” e soltanto nell’anno 1954, quando fu presentato il film ispirato sul suo racconto “La Lupa”, scritto da lui nel 1880, poteva essere trasmesso al mondo “la verità” della sua amata Sicilia perché non la fotografia, ma il cinema è “verità 24 fotogrammi al secondo”.
Gli anni 70
La fotografia nacque nel 1839 ma soltanto nel 1970 si accettò pienamente il concetto di fotografia come rappresentazione artistica. Nonostante ciò, la fotografia non riesce a togliersi di dosso il peso della verità, con ciò che ne comporta. Per l’opinione pubblica, nella fotografia, la realtà è superiore al concetto. Gli anni Settanta del secolo scorso erano il periodo in cui il concetto cominciò a farsi prepotentemente strada a discapito alla realtà. Nella nostra epoca, siamo abituati ad osservare attraverso le lenti della fotografia, spesso distante dalla realtà, realtà eppure sempre presa come punto di riferimento.
Con la fotografia si può facilmente rappresentare un concetto falso, legato ad una realtà che non esiste, per esempio ritoccando, in certi punti, il corpo fotografato di una modella, per mostrarla più bella oppure più snella, immagine da proporre in seguito al pubblico. Tale immagine fotografica non è dunque verità. Oppure, con un filtro del mezzo tecnico, si può ammorbidire la pelle del soggetto ritratto con la macchina fotografica con una luce molto dura e cosi rappresentare un concetto falso, che nulla c’entra con “la verità”. Anche i numerosi fotomontaggi che sono stati creati, rappresentano un concetto falso, lontano dalla realtà. Il concetto può dunque vincere sulla realtà.
Il tempo fermato
La fotografia ferma il tempo, rendendo quei attimi di tempo eterni, anche se il tempo prosegue. Oggi, l’attimo, immortalato con la macchina fotografica non viene considerato come “una verità” ma viene considerato una rappresentazione della realtà, pur essendo dunque la fotografia sovente molto lontano dalla realtà.
Nel suo libro: “Il valore dell’attimo” (1941), Guido Piovene, scrittore e giornalista italiano (1907-1974), illustra la complessità dell’attimo: «La grande rivoluzione che la fotografia ha portato nell’uomo è stata quella di insegnargli il valore dell’attimo. Gli ha insegnato il gusto profondo, l’intimo senso che si trova in ogni attimo della nostra vita: un senso che sfugge vivendo, quando non si pensa a guardare la vita ma solo a sfruttarla. Solo la fotografia ha saputo dividere la vita umana in una serie di attimi, ognuno dei quali ha il valore di una intera esistenza e che senza di essa era destinata all’oblio.»
Conclusione
Come conclusione si può affermare che la fotografia “non è la verità” ma che è una rappresentazione della realtà, di un istante e che non si può più toccare questo istante; che una fotografia è una testimonianza di un frammento di tempo, di un’attimo di tempo immortalato in un’immagine definitivo; che la fotografia dona soltanto “un senso della verità”; che “la verità” non sempre corrisponde alla realtà; che realtà e verità non collidano sempre; che la fotografia è reale ma non vera; che la fotografia non ha linguaggio, cita piuttosto di tradurre; che la fotografia può ingannare. Sappiamo oggi che una foto deve essere attentamente osservata ed interpretata ma che ognuno di noi può dare un significato diverso ad una foto.
Possiamo, dunque, ritornare agli scritti degli antichi filosofi greci per chiudere questo excursus sul rapporto della fotografia con la verità.
La realtà è stata letta fin dall’antichità attraverso i rapporti che forniscono immagini e, da Platone in poi, i filosofi hanno cercato di attenuare la dipendenza dalle immagini evocando i modelli di comprensione del reale indipendente dalle immagini stessi.
(SFA, Filosofia dello Spettacolo, con Mario Restagno – Relazione a cura di Fabrizio Merlo)